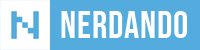Recensione
Che vi posso dire? Io quando mi innamoro di un’artista (e ne ho più d’una in casa che amo alla follia) non posso fare a meno di seguirla nell’attesa della sua prossima manifestazione artistica.
Con Masaya Martina (cognome prima del nome non per ragioni bejoriane, ma perché a lei piace così), che ho avuto modo di conoscere ormai anni fa e che seguo da allora, è stato così: e per tutte le passioni più profonde, mi viene difficile dare forma al suo perché. Potrei usare grandi giri di parole, ma la verità pura e semplice è che probabilmente lei riesce, tramite il suo lavoro, a dialogare con la mia anima (in un’accezione squisitamente psicodinamica).
Il che è ancor più straordinario pensando che probabilmente non esiste persona più lontana da me, eppure eccomi qui, ancora una volta, a commentare per voi la sua ultima fatica. Ed è una di quelle che colpisce duro e sotto la cintura.
Trama
La protagonista di Junkie è Anna: una giovane ragazza in lotta con se stessa. È l’alter ego di Martina? Forse sì, forse no (io penso di sì per una buona parte, ma non glielo chiederò per rispetto al mistero del processo creativo); forse solo a tratti; forse in realtà sono io; o forse, più probabilmente, siamo tutti noi mentre abbiamo attraversato quella fase infame di crescita in cui ci sentiamo dei “diversi”.
Ma non solo diversi: ci sentiamo incompresi, messi alla prova da aspettative troppo grandi o troppo diverse dalla nostra natura più profonda e quindi sempre costantemente messi sotto giudizio. È qualcosa che parte dal profondo e che emerge in modo differente in ognuno di noi, ma non si scappa: è il nostro Super-io che si eleva a giudice supremo del tribunale della mente, ci pesa, ci misura e ci trova irrimediabilmente mancanti. E ci condanna, sempre e senza pietà, alla pena più severa: quella di sentirci inadeguati.
E allora cosa facciamo? L’unica cosa che ci riesce facile: ci rannicchiamo e ci rifugiamo nelle nostre addiction. Non vi svelerò qual è il “paradiso artificiale” di questa protagonista, lascerò invece a voi il compito di scoprirlo da soli e sorprendervi (forse in toto, forse in parte) nella risoluzione finale.
Ma, come spesso avviene, non è quella la parte più importante: bensì il viaggio. Possiamo rifugiarci nei libri fantasy (come alcuni illustri colleghi di Redazione), oppure nella fantascienza (come il sottoscritto ed altri illustri colleghi di medesima Redazione), o ancora in altre distrazioni che ci facciano sentire al sicuro: i videogiochi, i viaggi, la musica. Purtroppo anche le droghe (che in qualità di padre metto nella top 3 delle cose che mi terrorizzano in questo mondo) certo, ma non c’è bisogno di distruggersi fisicamente, per farlo invece psicologicamente.
Anna attraversa questo inferno personale dal quale non c’è apparente via d’uscita, perché come tutte le “dipendenze” hanno il doppio effetto di farci sentire al sicuro, finalmente compresi e in pace; eppure ci allontanano dal mondo reale, dalle persone vere, da quelli che magari ci stanno tendendo una mano senza chiedere nulla in cambio e che non riusciamo neppure a vedere.
E allora ci isoliamo ancora di più. Ci sentiamo più soli di quello che realmente siamo, e anche le voci amiche, quelle che fanno di tutto per starci vicino, suonano incessanti come sirene malefiche alle nostre orecchie, facendoci sentire ancor più soli, ancor più incompresi.
Se ne può uscire? Naturalmente sì, ma come?
Ecco: torniamo a quel tema del viaggio di cui sopra. Perché è il viaggio ad essere la cosa più importante? Molto più del traguardo? Perché, una volta raggiunta la fine, la cosa più importante è intraprenderne un altro?
Perché, a mio modesto parere, è solo tramite quello che si può crescere: scoprire cose nuove su di sé e su chi ci circonda. E per farlo non occorre nemmeno portarsi dietro un bagaglio troppo voluminoso, basta una cosa: il nostro cuore, ma assicurandosi che sia bene aperto, se non spalancato, a quanto la società e il mondo attorno a noi sia pronto ad offrirci.
Facile? No: non lo è e non lo sarà mai. Ma c’è da essere orgogliosi per qualsiasi piccolo passo in questa direzione.
E dunque Junkie è il viaggio di Martina? Forse, ma in ogni caso spero che il sorriso che spesso sfoggia nei suoi selfie sia lo specchio di quel traguardo, del coronamento di quel viaggio. Personalmente non posso che essere emozionato e felice nell’aver avuto il privilegio di poter partecipare da recensore ad un’altra delle sue opere.
Stile
Inconfondibile, come sempre, lo stile grafico di Martina: delicato, morbido, arricchito da trame cinetiche che ti fanno precipitare nel cuore dell’azione. Come dite? Non è un fumetto action? E chi lo dice? C’è davvero più azione in una graphic novel supereroistica che in una introspettiva? Io non credo proprio.
Riquadri dal taglio originale, schemi infranti, personaggi che sembrano saltar fuori dalle griglie se non dalle vere e proprie pagine. Tutto nello stile di Martina grida al vortice, al movimento senza fine, e il tutto in perfetto contrasto con la usuale scelta di colori acquerello, morbidi e pacifici, capaci quindi di creare un cortocircuito emotivo travolgente, che spiazza ad ogni pagina sempre di più, man mano che procediamo nella narrazione.
Saltando sapientemente da colore a scala di grigi, questo albo è la dimostrazione di come la componente grafica possa accompagnare la trama nel suo dipanarsi in un viaggio introspettivo così come fece Virgilio con Dante.
Non voglio dilungarmi oltre: seguitela sui social e lasciate che la sua arte vi regali qualche emozione. Se lo merita. Ve lo meritate.
Nerdando in breve
Junkie è il viaggio di perdita di se stessi e ritrovamento, creato della talentuosa Masaya Martina.

Contenuti