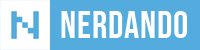Indiana Jones and the Fate of Atlantis
L’avventura che NON vedrete al cinema.
Se, come me, siete stati giovani negli anni ’80 e primi ’90, c’è sicuramente un mito inossidabile che popola da sempre le vostre fantasie più sfrenate.
Un personaggio apparso tre volte al cinema (sì, sarebbero quattro ma l’ultima è meglio dimenticarla) e di cui il suo regista, Steven Spielberg, disse: “Insieme ad E.T., è l’unico dei miei personaggi di cui potrei proiettare l’ombra sul muro e tutti lo riconoscerebbero”.
Un mito assoluto, granitico, ironico, coraggioso, tombeur de femmes, intelligente, avventuroso. Un mito per il quale le vecchie VHS sono state consumate fino all’essere illeggibili, che è sopravvissuto per decenni arrivando a sconfinare in tutti i media, dal videogioco, ai Lego ad… entrambe le cose contemporaneamente.
Sto parlando, naturalmente, di Indiana Jones.
Per chi, come me, è entrato in crisi d’astinenza nell’esatto istante in cui è finito l’ultimo fotogramma dei titoli di coda de L’ultima crociata, il rivivere le gesta del nostro eroe attraverso i videogiochi è stata una vera manna dal cielo. Potrete quindi immaginare con che emozione abbia salutato l’arrivo sul mio storico Amiga 1200 di Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Avventura grafica punta & clicca curata (ovviamente) dalla LucasArts, che già aveva regalato grandi gioie con lo sviluppo di Last Crusade.
Per chi conosce in modo approfondito le avventure grafiche non è certo una novità, ma per chi invece conosce solo Monkey Island e pensa che l’enigma della canzone degli scheletri di MI2 fosse roba tosta, ebbene: le avventure grafiche di Indy erano assolutamente degne di questo nome.
Non siamo ai livelli cervellotici di Zak McKracken o di follia estrema quali Maniac Mansion, tuttavia gli enigmi di Indy (e la possibilità di morire anzitempo) rendevano le avventure della LucasArts molto più che un semplice intrattenimento videoludico: erano una vera sfida con sé stessi. E non sono certo io l’unico a cui è capitato di arrivare alla fine e scoprire di dover ripartire da metà gioco perché mi ero dimenticato un apparentemente insignificante oggetto in qualche remoto livello (qualcuno ha detto “la foto del vero Santo Graal nel castello di Brunwald”?).
Stiamo parlando anche di anni in cui non esisteva Internet e non esisteva quindi nemmeno Youtube e le soluzioni (invise ai veri nerd) venivano comunque servite solo grazie alle riviste di settore come K e TGM.
Stiamo anche parlando di anni in cui un gioco doveva durare settimane, se non mesi. Il mordi e fuggi dei nostri giorni era un concetto totalmente alieno all’epoca e le avventure grafiche erano le uniche forme di videogioco in cui esistevano scelte multiple, trame alternative e finali differenti (c’è qualcun altro che ha scelto “dai un pugno” ad Hitler invece del diario? Si, sono morto: ma che soddisfazione!).
Indiana Jones and the Fate of Atlantis aveva tutto quello che ci si aspettava da un’avventura di Indy: azione, mistero, ironia, archeologia e una bella bionda ad accompagnarci. La storia vedeva il famoso archeologo girovagare per mezza Europa alla ricerca di indizi che lo avrebbero condotto nella mitica città di Atlantide. Qui gli atlantidei avevano collocato una macchina capace di trasformare gli esseri umani in dei; ovvio, quindi, che un potere del genere facesse gola agli immancabili nazisti, ed eccoci proiettati in toto nell’ambientazione tipica del franchise di Indiana Jones.
Se con Monkey Island 2 avevamo la possibilità di giocare due storie (una facile, una con tutti gli enigmi), qui la LucasArts superò sé stessa, mettendo a disposizione ben tre linee narrative: Azione, Squadra e Ingegno. Non solo cambiava la storia, ma veniva modificato profondamente il modo di risolvere l’avventura. Tutta la parte centrale, infatti, poteva essere affrontata secondo dinamiche completamente diverse, il che si rifletteva non solo sul gameplay, ma anche sullo storytelling. In pratica era possibile arrivare al capitolo conclusivo affrontando il titolo nel modo a noi più congeniale. Con Azione veniva dato risalto ai combattimenti (già presenti nel gioco precedente e decisamente poco eccelsi dal punto di vista tecnico); chi optava per Squadra avrebbe potuto contare sull’aiuto della coprotagonista Sofia per risolvere le situazioni; infine, per chi amava distruggersi le meningi, c’era l’opzione Ingegno, tutta incentrata sulla risoluzione di complicatissimi enigmi.
La grandezza del titolo, e vi ricordo che siamo nel 1992, non si limitava a questo: le interazioni di Indy con gli altri personaggi, la posizione degli oggetti e le scelte di dialogo erano tutti elementi che influenzavano il gameplay. Oggi gridiamo al miracolo (e a buon ragione) per uno storytelling articolato e sfaccettato come quello di Life is Strange, ma la verità è che queste cose esistevano già 25 anni fa, solo che poi i game designer se ne sono “dimenticati”.
Infine: la conclusione. Il gioco poteva terminare in tre modi diversi: bene, male, malissimo. E questo solo escludendo le molteplici gamme di decesso di Indy.
Insomma, un gioco semplicemente epico. Non è un caso se su Amiga il gioco richiedesse la bellezza di 11 floppy disk: una mostruosità per l’epoca.
Chiudo con una piccola curiosità: per molti anni è girata la leggenda metropolitana che, nonostante il claim, FoA avrebbe costituito la base per il quarto film di Indiana Jones; tutto sommato, visto l’esito dell’ultima pellicola, forse avrebbe fatto bene a non restare un sogno ad occhi aperti.