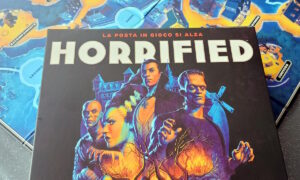Un mese fa mi sono svegliato e, come ogni mattina, ho acceso il cellulare ed ho iniziato a leggere i messaggi arrivati durante la notte giapponese/pomeriggio italiano. L’argomento principale delle conversazioni era la morte di Kobe Bryant.
Il mio cervello non esattamente brillante a nessun’ora del giorno, specialmente nei primi minuti dopo essere rinvenuto da quello che dovrebbe essere sonno, in un primo momento non capiva bene cosa fosse successo.
Eppure la realtà era molto semplice, un elicottero si era schiantato causando la morte delle 9 persone a bordo, tra cui l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers e la sua secondogenita.
In brevissimo tempo, Facebook, Twitter e giornali vari si affollavano di parole, storie ed articoli, mentre tutto il mondo davanti ai miei occhi sembrava essere entrato in uno stato di stupore e lutto (a volte anche coloro che probabilmente a malapena sapevano chi Bryant fosse, come ricorderebbe Zero Calcare in “Quando muore uno famoso”).
Ad ogni modo, dopo un paio d’ore ce l’ho fatta anche io a capire cosa fosse successo. Afferrato il concetto, ho scrollato le spalle e ho proseguito la mia giornata, ignorando quali sentimenti dovessi provare o fosse naturale provare di fronte a ciò.
Kobe Bryant è il mio più grande eroe.
Quando parlo di “eroe” ciò che intendo è l’accezione più mitologica e mistica della parola. Bryant per me non è mai stato una persona in carne ed ossa: era un essere che viveva una vita che non era parte del mio stesso mondo o di quello delle persone normali. Qualcuno che si può guardare solo attraverso uno schermo, perché nella realtà non può esistere.
È questo il grande potere dello sport, soprattutto quello americano: ai miei occhi da bambino, quelle che guardavo non erano partite, ma battaglie in cui persone dai superpoteri si fronteggiavano per decidere di un destino più alto.
Crescendo, ho imparato ad amare la pallacanestro in altri modi ed il cinismo, sorto da una migliore comprensione della realtà, ha intaccato la visione magica dell’NBA come di un qualcosa di uscito dalle pagine di un fumetto. Tuttavia, questa fascinazione infantile verso il personaggio “Kobe Bryant, supereroe in maglia gialloviola” non mi ha mai abbandonato.
Il modo in cui ho vissuto la sua carriera, i sentimenti che ho provato e le lezioni ed ispirazioni che ne ho tratto sono assimilabili al modo in cui seguo fumetti e libri fantasy: storie piene di difficoltà e tragedie in cui gli eroi alla fine vincono o muoiono.
Ricordo una mattina di dieci anni fa, dopo gara-5 delle Finals contro Boston vinta dai Celtics. Ero andato a letto alle 6, a partita finita, totalmente sconvolto da un turbinio di emozioni. Non soltanto la rabbia per la sconfitta, ma l’immane e brutale passione del modo in cui Bryant aveva giocato mi si era rovesciata addosso e mi toglieva il sonno.
Era stata una delle sua migliori partite di tutti i tempi, eppure sembrava stesse combattendo contro una marea inarrestabile. Oggi lo paragonerei forse al senso di ineluttabilità di Avengers: Infinity War. Al tempo però, mi richiamò alla mente qualcos’altro.
Così, incapace di prendere sonno, presi la mia copia del Silmarillion per leggere un capitolo che allora conoscevo a memoria: La Rovina del Beleriand e l’uccisione di Fingolfin. Nella mia testa non riuscivo a distogliermi l’immagine di Bryant come il furioso Re dei Noldor, che cavalca verso la sua fine contro un avversario invincibile, nonostante tutto il suo valore.
Quella serie finì con la vittoria dei Lakers in gara 7. La storia doveva continuare ed il nostro eroe aveva ancora battaglie da combattere e vincere.
Era questo il modo in cui vivevo le partite di Bryant: avventure epiche che si presentavano a me sullo schermo, ambientate in un mondo che allo stesso tempo era il mio ma anche un altro piano irraggiungibile.
Con questa mentalità e questa intensità approcciai la fine.
Nel 2013 quella storia, quella del mio eroe, era inaspettatamente al termine, durante una stagione che più che mai sembrava frutto della penna di un autore della Marvel.
Di nuovo, una notizia di prima mattina: Kobe Bryant si era rotto il tendine di Achille. Il mio eroe era, dal punto di vista della pallacanestro, arrivato alla fine.
La realizzazione in questo caso mi devastò immediatamente. Mi sentivo come se il libro che stavo leggendo avesse raggiunto l’ultima pagina senza che mi avvedessi che fosse così vicina.
Memore di questi sentimenti, per certi versi capivo la mia mancanza di una reazione forte: mi sentivo come se la persona che fosse morta non fosse il mio eroe. Era l’attore che l’interpretava.
Ovviamente, la realtà delle cose non è questa e non c’è distinzione tra Kobe Bryant giocatore di pallacanestro e Kobe Bean Bryant, morto in un incidente. Ma la mia mente rifiutava di considerare la possibilità: le persone reali muoiono così a caso, una mattina qualunque, mentre gli eroi invece spirano al termine di battaglie epiche. In tal senso, nella mia testa, il suo trapasso era molto più facile da assimilare all’infortunio di cui parlavo prima.
Nei giorni successivi però ho iniziato a vedere qualcosa che ha cambiato tanto la mia prospettiva, quanto i miei sentimenti. A Los Angeles ed in tutto il mondo iniziavano ad apparire tributi ed in generale si poteva percepire un senso di perdita che mai avevo sentito o visto in vita mia.
Mi ci sono voluti giorni per capire cosa mi ricordasse (ho già detto che il mio cervello è lento mi pare).
In quel capolavoro che è Into the Spider-Verse, una delle scene che più mi ha colpito è quella della reazione degli abitanti di New York alla morte di Spider-Man. In pochi secondi dall’annuncio, la città intera si ferma e sembra persa come un adolescente che ha appena visto la sua cotta baciare un altro.
Per i newyorchesi di Spider-Verse, Spider-Man era vero, ma allo stesso tempo non lo era mai stato completamente fino al suo trapasso, quando dal misterioso amichevole Uomo Ragno di quartiere è diventato Peter Parker, ricercatore di 26 anni del Queens.
La morte di Kobe Bryant, l’uomo, ha generato la stessa reazione: per me, per molti, era successo l’inspiegabile. L’eroe, quello che viveva in un mondo diverso da tutti, era diventato reale nel più crudele dei modi.
È passato del tempo da allora e, con la cerimonia del 24 febbraio, si è sostanzialmente concluso il periodo di lutto per l’NBA e per il mondo.
Mi ci è voluto ogni singolo istante fino ad ora per arrivare a capire cosa significasse per me la morte del mio eroe. Cosa stessi provando, cosa potessi portare con me che mi possa aiutare da qui in avanti.
Kobe Bryant è il mio eroe, quella figura mitologica che combatte contro tutto e tutti e rende possibile l’impossibile su un campo da basket che è una metafora della vita. È quello che sbaglia cento volte ma non si arrende mai, anche se significasse sbagliare altre mille. È quell’eroe tragico a cui il lieto fine è precluso, perché se lo avesse sarebbe solo uno dei tanti.
Soprattutto, è quello che mi ha mostrato ancora una volta che quell’inafferrabile fantasia epica che cerco in libri e fumetti può esistere non solo in quel mondo dove ha vissuto, dietro uno schermo, ma anche in quel mondo dove vivo io, e dove lui è morto.